La partita cruciale dell’Est
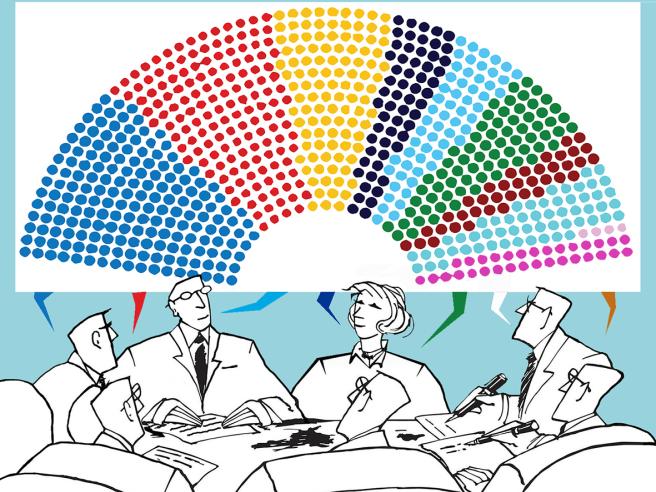
Nei Paesi collocati fra Russia e Unione europea si sta oggi giocando una partita cruciale per il destino della democrazia. A Est, incombe il tallone autoritario di Putin, che già calpesta il territorio ucraino e una parte della Moldavia. Da Ovest arriva la forza di attrazione di Bruxelles, ma si agitano anche i tentacoli illiberali di Orbán, che stanno avvolgendo i Balcani occidentali (Serbia, Bosnia). Dopo le elezioni presumibilmente truccate di domenica scorsa, il leader ungherese è volato a Tbilisi per congratularsi con Sogno Georgiano, il partito filo-russo che ha «conquistato» la maggioranza parlamentare. Fra gli effetti esterni dell’invasione in Ucraina vi è stato anche quello di fiaccare l’entusiasmo filo-occidentale nei Paesi ex sovietici: se il rischio è quello di subire una «operazione speciale» come quella ucraina, meglio tenersi una qualche forma di semi-autocrazia, purché nazionale.
L’Unione europea è sinora rimasta compatta di fronte a Putin, ma fatica a contenere Orbán. Il quale ha sì perso il proprio fratello polacco (il sovranista del Pis, Morawiecki, sconfitto dal popolare Tusk), ma può contare su simpatie e vicinanza da parte di molti leader di partiti europei e persino di qualche leader di governo. Il virus illiberale può oltrepassare facilmente il fragile «cordone sanitario» attivato contro le destre nel Parlamento europeo. Le minacce alla democrazia tendono a partire dall’alto, per iniziativa di leader populisti alla Orbán.
Ma il loro successo dipende anche dalla situazione «in basso», dagli orientamenti dell’opinione pubblica. È lì che dobbiamo guardare per valutare il grado di immunità al virus, soprattutto in seno alle democrazie consolidate, quelle della «vecchia» Europa pre-allargamento.
Che cosa ci dicono sul tema i dati disponibili?
Dai sondaggi emergono indicazioni contrastanti. Gli elettori continuano ad esprimere un sostegno abbastanza robusto per le componenti elettorali e sostanziali della democrazia. Sono consapevoli dell’importanza di un’informazione pluralistica e attendibile, di un dibattito aperto e trasparente fra i candidati, della libertà di esprimere le proprie opinioni e il proprio voto senza temere conseguenze negative. Gli stessi elettori si rendono anche conto che è essenziale disporre di una infrastruttura organizzativa capace di proteggere il voto popolare da interferenze straniere, imbrogli, finanziamenti illeciti. Al tempo stesso, emerge una significativa associazione tra sostegno alla democrazia elettorale e aspettative di sicurezza sociale e redistribuzione. La gente valuta positivamente le libere elezioni perché queste incentivano i governi a tutelare il benessere. Un dato che non dovrebbe stupire: dopo tutto il «modello» europeo si distingue nel mondo proprio per lo stretto connubio tra democrazia e welfare.
A risultare più vulnerabili sono le componenti liberali della democrazia: la protezione costituzionale dello Stato di diritto, delle minoranze, dei contrappesi al potere esecutivo. Anche in Russia «il popolo parla», come dice Salvini, durante le elezioni. In assenza di garanzie costituzionali, l’esercizio dei diritti politici si esaurisce tuttavia nel porre la crocetta accanto all’unico nome presente sulla scheda.
Il cedimento del sostegno ai principi liberali è segnalato da vari indicatori. È aumentata l’insofferenza verso i vincoli istituzionali al potere esecutivo, verso l’espressione in pubblico di opinioni considerate offensive dalla maggioranza ed è cresciuta la domanda di un «uomo solo al comando». Secondo il Pew Research Center di Washington, la percentuale di elettori che sosterrebbe un governo guidato da un leader forte (fosse anche un militare!), in grado di decidere senza troppe interferenze da parte del Parlamento o altri organi, ha raggiunto il 37% nel Regno Unito e si colloca tra il 20% e il 30% in Italia, Francia, Spagna, Grecia e Polonia. Negli Usa, dove si vota fra meno di una settimana, la percentuale è del 32%. E in un recente sondaggio pubblicato sul New York Times il 29% degli elettori americani riterrebbe del tutto ammissibile per un presidente violare la legge pur di realizzare il suo programma.
I dati di sondaggio vanno ovviamente presi con le pinze. Quando sono confermati da diverse fonti, sarebbe però un errore ignorarli. Dobbiamo dunque prendere atto di una preoccupante divaricazione tra la dimensione popolare e sociale della democrazia e quella costituzionale e liberale. Nella migliore delle ipotesi, la seconda viene data per scontata, nella peggiore viene invece percepita come un disturbo, se non un ostacolo a un modello che alcuni esperti già chiamano «nazionalismo maggioritario». Purtroppo non c’è un antidoto capace di neutralizzare rapidamente il virus illiberale. L’unica strategia efficace è quella di una persuasione mirata, soprattutto verso i giovani, che ribadisca il nesso inscindibile fra garanzie liberali e democrazia sociale. C’è però da chiedersi se fra le nostre élite (politiche) esista ancora chi crede in questo nesso e ritenga perciò importante impegnarsi concretamente per difenderlo.

Comments
Post a Comment